Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera
Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera
Il film è ambientato in un eremo buddista al centro di un lago in una foresta incontaminata, e racconta la vita di un monaco buddista attraverso le stagioni della sua vita.
Il regista interpreta l'uomo nell'ultima fase della vita. La tranquillità contemplativa del film ha segnato un cambiamento significativo dalle sue opere precedenti, che sono state spesso criticate per eccesso di violenza e misoginia. Il film è diviso in 5 segmenti (le cinque stagioni del titolo), e ogni segmento descrive una fase differente della vita di un monaco buddista.
Primavera
La storia comincia con la presenza di un anziano monaco e del suo giovanissimo discepolo, che vivono in un eremo galleggiante al centro di un laghetto. Durante la "primavera" della sua esistenza, il giovane novizio scopre l'importanza e il rispetto della vita, grazie soprattutto alla rigida educazione impostagli dal suo maestro. Infatti questo, per punire il bambino per il suo atteggiamento violento e cinico nei confronti di alcuni animali del bosco, lo punisce infliggendogli la stessa pena.
Estate
La vita del giovane monaco, divenuto ormai un adolescente, viene stravolta dall'arrivo nell'eremo di una donna con sua figlia, anche lei adolescente ma malata. Alla richiesta della madre, il vecchio monaco permette alla ragazza di restare nel monastero per poter curare il suo male, anche se il maestro ritiene che il problema non sia fisico, bensì interiore. La presenza della ragazza turba profondamente il giovane monaco, al punto che i due cederanno alle loro tentazioni, apparentemente all'insaputa del vecchio monaco. Il giovane monaco, innamorato della ragazza ormai guarita e partita per tornare nel mondo "reale", scapperà dall'eremo per poterla raggiungere.
Autunno
Il vecchio monaco continua la sua vita solitaria nell'eremo e, per caso, scopre su una pagina di giornale che un trentenne è in fuga dopo aver ucciso sua moglie per gelosia. Il fuggitivo è proprio il giovane monaco, che si rifugia nell'eremo presso il suo maestro, e dove tenta anche il suicidio ma è prontamente fermato dal vecchio. Per aiutare a ritrovare la pace interiore, il vecchio monaco assegna al giovane un lavoro di grande calma e meticolosità: incidere nel legno del basamento del tempio l'intero testo cinese del Sutra del Cuore della Perfezione della Saggezza, che egli stesso dipinge sul legno. Intanto, però, due poliziotti riescono a scovare il giovane omicida ma accettano, su richiesta del maestro, di portarlo via solo a lavoro concluso. L'indomani mattina il giovane termina il lavoro e parte con i due poliziotti. Tempo dopo il vecchio monaco, ormai invecchiato e debole, decide di mettere fine alla sua vita, consapevole di aver adempiuto al suo compito, dandosi fuoco su una pira funebre nella sua barca al centro del lago. Dalla barca esce un serpente, che entra nell'eremo.
Inverno
Ormai divenuto un uomo maturo, il discepolo del defunto maestro torna all'eremo, dove tutto è ghiacciato per il freddo, con il serpente lì ad aspettare. Dopo aver scoperto la fine del proprio maestro, il monaco comincia ad esercitarsi nelle arti marziali. Ma la sua vita cambia allorquando una giovane donna lascerà nel convento alle attenzioni del monaco, il suo piccolissimo figlio. Questa mentre cerca di allontanarsi nel cuore della notte, cade in un buco nel lago ghiacciato che il monaco aveva scavato in precedenza per estrarre l'acqua per bere e lavarsi, e finisce annegata. Il giorno successivo il monaco ritrova il suo cadavere, e reagisce legando al suo corpo la grande pietra circolare del monastero e si arrampica sulla sommità della montagna circostante più elevata portando un'altra statua, che dispone lì, rivolta verso il lago.
... e ancora primavera
Il ciclo della vita riprende: il monaco si prenderà cura del bambino, che intanto è cresciuto, così come il vecchio defunto monaco aveva fatto tempo addietro con lui.
SIGNIFICATO
Questo racconto potrebbe essere interpretato e letto attraverso una moltitudine di chiavi diverse, come la metafora, la differenza fra bene e male, la crescita, ma l’aspetto che più mi ha colpito è la presenza di molti “confini”. I confini delle stagioni, i confini delle età di un essere umano, i confini fisici e astratti, i confini fra silenzio e rumore, confini veri e falsi, che mettono in crisi con il dubbio della loro esistenza, confini complementari. La scena iniziale si apre con una porta, una soglia, un confine che è esso stesso all’interno di un altro sistema di confini: il lago è separato dal bosco, il monastero è separato dal lago, l’interno del monastero è senza pareti, ma le stanze sono divise da porte senza muri che indicano un ambito e un utilizzo privato, personale, diverso dagli altri. Ogni soglia è quindi un confine, con una sua specifica materialità e significato, la cui accezione non è per forza negativa, non indica un ostacolo o una schermatura, ma una semplice divisione, un cambiamento, una variazione morfologica o di significato. I protagonisti del film attraversano molti bordi, molti confini durante la loro vita, in tempi e con comportamenti diversi e capiscono lentamente il significato stesso di confine, come per esempio quello tra divertimento e dolore: il piccolo allievo si diverte a legare una pietra al corpo di tre animali, impedendogli il movimento. Solo successivamente capirà il valore dei suoi gesti e come questi abbiano pesi diversi a seconda di chi li subisce e di chi li attua.
I dialoghi sono ridotti al minimo e non sono realmente necessari per comprendere il senso delle immagini, quindi sono preponderanti i suoni del mondo naturale del film e il silenzio interiore dello spettatore, assorto da una realtà meditativa, lontana dagli affanni della “vita mondana” che appesantiscono il giovane uomo ritornato dal vecchio monaco che l’ha cresciuto.
I bambini disegnano la loro realtà e la loro fantasia tracciando prima di tutto i bordi neri dei soggetti, forse per avere conoscenza della forma e prova dell’esistenza di ciò che disegnano, come a dire: “Se ne delineo i confini, allora esiste”. Poi da grande ti insegnano a non disegnarli più, oppure ti fanno notare che non sono così imprescindibili dall’esistenza della realtà, perché ci sono anche se molte volte non sappiamo riconoscerli.













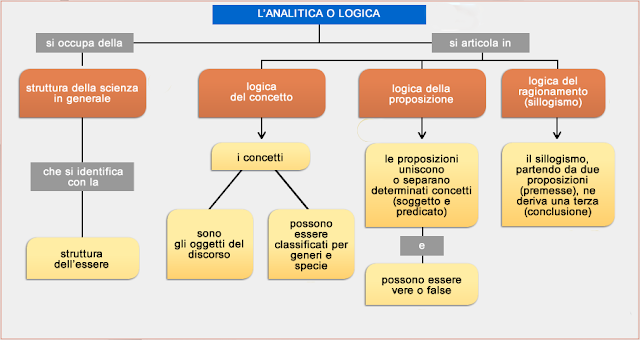

Commenti
Posta un commento